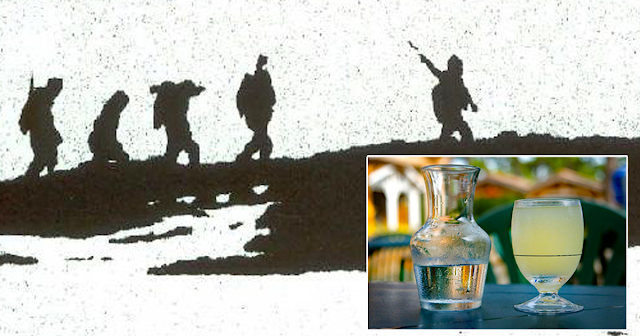Gli spazi dell'antico monastero agostiniano di San Michele all'Adige, che è culo e camicia con il celebrato vino principe del Trentino.
 |
I chiostri di conventi ed abbazie erano a pianta quadrata ma quello di San Michele
fa eccezione: è triangolare. Il monastero fu fondato nel 1144-45 dai conti di Appia-
no in favore dei
"canonici regolari" agostiniani, parallelamente alla istituzione dei
conventi dei canonici regolari di Novacella presso Bressanone e di S. Maria in der
Au presso Bolzano. | |
Non c'è da stupirsene poichè nei tempi andati dove c'erano i frati c'era anche il buon vino.
Naturalmente anche gli Agostiniani di San Michele avranno conosciuto l'arte del vino retico, da queste parti la vite era coltivata fin dal tempo dei romani ma non esistono prove che il vitigno sia stato "inventato" o "scoperto" dai monaci.
 |
Secolarizzato nel turbine napoleonico, passò poi all'amministrazione pubblica austriaca che nel 1874 vi attivò una scuola agraria con nnessa stazione sperimentale per fare rinascere l'agricoltura del Trentino, allora in grave crisi. Oggi l'antico monastero ospita il conosciutissimo Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.
|
|
👉L'incertezza sull'origine non trattiene i divulgatori dal fare affermazioni apodittiche, come quella di Elio Fox (tratta dal suo "Storia delle osterie trentine", Editrice Innocenti, Trento, 1974, pag. 3): "Verso il 1145 furono i monaci agostiniani a curare amorevolmente la vite, e da un vitigno particolare che cresceva sulle colline nei pressi dell'Abazia di San Michele all'Adige, fecero un vino eccezionale: il Teroldego."
👉In ogni caso questa vigna è veramente autoctona e di antica origine, visto che nel basso medioevo il Teroldego era già conosciuto, come attestano atti notarile del tempo (anche se la datazione rimane incerta: 1383 oppure 1480?).
👉Nemmeno sull'origine del nome ci sono notizie certe; mentre alcuni ricordano correttamente un Teroldeghe toponimo locale, secondo altri sarebbe una deformazione del termine Tirodola, vitigno diffuso nell’alto Garda che prende il nome dalla tipologia di allevamento a tutore vivo, le cosiddette
tirelle. Secondo altri il Teroldego altro non sarebbe che il Tyrolergold, vitigno "già conosciuto in Germania in epoca tardo-medioevale". Nel tentativo di retrodatare le nobili ascendenze le citazioni "ad minchiam" si sprecano:
"In realtà si parla di questo vitigno già ai tempi del Concilio di Trento, ne parlò poi Paolo Diacono" (ma il Concilio si tenne dopo, dal 1545 al 1563, e il longobardo Paolo Diacono visse prima, dal 720 al 799 d.C.) Ancora:
"il nome lo diede per la prima volta per scritto Paolo Diacono, alla
fine dell’VIII secolo, raccontando nella sua Historia Langobardorum una
cruciale battaglia tra i Longobardi e i Franchi per il controllo della
via del Brennero" quando una veloce verifica mostra che la
ricerca per lemmi nel testo originale latino ha esito negativo).
 |
| Dal Monte di Mezzocorona la cannibalizzazione dei terreni agricoli è drammaticamente evidente. Capannoni e edilizia in puro stile "Padania Classics" si sono bevuta una buona metà "patria del Teroldego". |